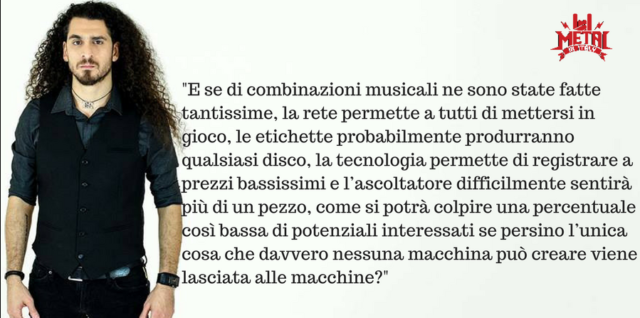Cosa si è perso negli anni? Perchè sembra che le nuove generazioni non riescano ad essere all’altezza delle “vecchie”? Eppure, di strumenti, di nuovi innesti tecnologici, ce ne sono e tutto dovrebbe essere ancora più facile.
Non è così ed è tutta una questione di “personalità”.
E’ questa la visione di un musicista, di un cantante, di chi vive a 360° il pianeta musica e si è reso conto di quanto stiamo perdendo e perchè.
Michele Guaitoli, voce di Kaledon ed Overtures, ha voluto condividere con Metal In Italy questa sua riflessione, sperando di poter aprire un dibattito e, perchè no, cercare di smuovere gli animi.
Riflessioni:
Mi è capitato sempre più spesso ultimamente di trovarmi a chiacchierare con vari amici musicisti riguardo ad un tema piuttosto classico: “Cosa si è perso nelle nuove generazioni rispetto ai grandi classici, a livello musicale?”.
Per affrontare questa questione è necessario a mio parere fare un lunga ma importantissima premessa: anteponiamo alla risposta un’analisi del panorama moderno con quelle che sono le risposte tipiche a questa domanda. Risposte che aprono un po’ la mente e fanno riflettere …ma a parere mio non rispondono al 100%.
Qual è la risposta? Il suono… abbiamo perso l’importanza del suono…
Ma tempo al tempo.
Cosa si è perso? Le risposte che sicuramente avrete dibattuto anche voi nelle vostre riflessioni a riguardo, sono molteplici:
– C’è chi sostiene che sia già stato detto tutto e che quindi si possa soltanto riciclare idee che i grandi del passato abbiano già scritto, inventato, prodotto e che il futuro non possa fare altro che riservarci il passato leggermente modificato;
– C’è chi sostiene che la colpa sia della rete che ha aperto le porte a tutti, senza una selezione “professionale”: quella che una volta veniva fatta dai talent scout che nel bene e nel male decidevano le sorti del futuro del mercato discografico… diventa inevitabile che in questo mare di proposte l’ascoltatore si ritrovi spaesato e non più concentrato nella sua stessa scelta. Venendo bombardati da proposte, per quanto possano essere ottime, in sostanza ci si perde nella mischia;
– C’è chi sostiene che la colpa sia delle etichette: sempre più etichette minori vivono con i soldi che le band stesse pagano… in sostanza per auto-prodursi. Il costo che ha la label per stampare e distribuire i dischi è inferiore al costo che viene richiesto alla band stessa per “partecipare alle spese di produzione” del disco, ed ecco che 10 band mantengono un’etichetta anche se non vende un solo disco. In questo contesto al discografico di turno non interessa assolutamente la qualità del prodotto: quello che conta è la pagnotta portata a casa… e quello che arriva al pubblico è un mondo così tanto saturo di bassa qualità che le poche perle vengono perse;
– C’è chi sostiene che la colpa sia al 100% agli ascoltatori e ai metodi di ascolto moderni. Spotify, Youtube, iTunes… ci siamo abituati (magari non noi musicisti direttamente, ma l’ascoltatore medio si) ad ascoltare e ricercare “quella canzone che mi piace un sacco, di cui non ricordo il titolo, dai quella che fa così… è una delle mie canzoni preferite”.
Tornando indietro di qualche anno, l’uscita di un nuovo album prevedeva un rito. Un rito che iniziava mesi prima dell’uscita del disco stesso con il piacere dell’attesa, che sfociava poi nella corsa all’acquisto, l’apertura del gioiello nelle mani, la seduta di fronte allo stereo con il booklet ed il suo profumo di carta ed inchiostro freschi ed infine l’orgasmo dell’ascolto leggendo i testi.
Una situazione decisamente differente dall’odierno, un momento che immergeva l’ascoltatore in un’atmosfera infinitamente intensa e profonda, magica.
Oggi l’attesa non esiste più, anzi è quasi un dovere della band sfornare prodotti di continuo, e da questi prodotti l’ascoltatore spesso fa l’errore immenso di “fidarsi dell’artista”. Il singolo è quello, non mi degno nemmeno di ascoltare il disco intero, se mi piace il singolo mi basta, se no la band non mi piace, anche perché con tutto quello che ho già da ascoltare non posso certo mettermi a sentire 10 album al giorno.
Come in tutte le situazioni, la verità sta dappertutto e da nessuna parte, o almeno questa è la mia opinione.
Sarà già stato detto tutto, ma l’emotività e le combinazioni di emozioni e musica non smettono mai di sorprendere, anche perché in ogni genere continuano a uscire cose fantastiche. Solo negli ultimi mesi “In the passing light of day” dei Pain of Salvation o brani come “Everybody Dies” degli Ayreon hanno dimostrato che perfino in un filone delicato come quello del metal melodico, di idee e intensità emotiva se ne possa ancora tirare fuori molta e che gli artisti sono ancora in gradi di sorprendere.
Band come i Destrage negli ultimi anni hanno portato aria nuova evolvendo le decadi precedenti, ma se si fa un salto nel passato, la storia ci insegna che questo è lo standard. Mozart, Beethoven… basta dare una letta a qualche libro di storia della musica per scoprire che come tanti, anche moltissimi classici erano “incompresi” nella loro epoca. Le loro composizioni più importanti sono state apprezzate solo in epoche successive, mentre nella loro epoca erano musicisti costretti a scrivere in base ai gusti delle corti per cui lavoravano, sentendosi limitati ed incompresi. La storia dell’artista che ha successo post mortem non è certo una novità. Allo stesso tempo la storia ci insegna che è dall’evoluzione che nascono i generi ed è sempre la storia ad insegnarci che l’epoca di uscita di molti artisti non corrisponde con l’accettazione degli artisti stessi, appunto.
Quanti artisti “estremi” per la loro epoca, oggi sono decisamente “leggeri” e fin classici? I Metallica sono l’esempio esasperato di questa situazione, se oggi prendiamo le band metalcore più estreme e le paragoniamo ai Metallica dei primi anni ’80, la situazione a livello di accettazione cambia davvero?
Nelle biografie si legge di quanto fossero “quattro ragazzini esaltati che suonavano punk più veloce e con le chitarre più distorte”. E andando a ritroso si passa per artisti ed artisti che hanno fatto la storia con l’estremo. Cobain, i Beatles, i Rolling Stones, Elvis… tutti artisti “estremi all’epoca”, con un’ indiscutibile importanza culturale oggi (al di là di qualsiasi gusto).
Torniamo però alla base.
Torniamo alla domanda: “Cosa si è perso nelle nuove generazioni rispetto ai grandi classici, a livello musicale?”.
C’è una risposta a questo quesito che a parere mio arriva troppo poco spesso e solo pochissime volte è stimolo di riflessione, eppure è assolutamente la cosa più importante!
Sento spessissimo parlare di tutti gli argomenti trattati sopra…ma quasi mai sento rispondere “si è persa l’importanza del suono”.
Eppure l’opinione del sottoscritto è proprio che il fulcro di tutto stia nel suono e nella ricerca sonora! Eppure proprio su una delle caratteristiche vitali del mondo della musica, si è passati ad un’approssimazione devastante.
“Ma come, proprio oggi che la qualità audio è migliorata tantissimo? Proprio oggi che fare un disco che suona male è quasi impossibile? Ma cosa stai dicendo?”. Esatto, perché in realtà non sto assolutamente parlando di “qualità” del suono, ma di unicità del suono. Personalità e ricerca. Attenzione: non sto assolutamente parlando dell’unicità della composizione o del “sound” della band. Di gruppi capaci di essere unici ce ne sono a palate e guarda caso quasi sempre più dal vivo che in studio, visto che spessissimo si sente dire “cavolo dal vivo rendete il doppio che sul disco”.
Quello di cui sto parlando è dell’importanza della ricerca sonora e timbrica del singolo strumentista. L’importanza dell’unicità del timbro del cantante, del suono di chitarra e di basso, dei fusti della batteria.
Si mettano una mano sulla coscienza quelli che hanno registrato un disco (se musicisti) o stra-apprezzato un disco (se ascoltatori) con degli splendidi trigger sulla batteria, un suono re-ampato di chitarra e basso con il Kemper/Fractal del caso o con le teste dello studio perché “suonano da paura” e via avanti. Un risultato roccioso, pomposo, bombastico, dove ogni strumento trova il suo spazio, il sound generale devasta l’impianto e travolge l’ascoltatore. Una qualità ottima insomma, ma la personalità?
E’ vero che alcune cose sono inevitabili, ma altre stanno diventando sempre più “comode”.
Lars Ulrich sarà il batterista che è, ma la sua cassa si riconosce in un istante. Così come bastano pochi istanti per riconoscere il sound di band come U2, Aerosmith, Iron Maiden, Queen, Guns’n’Roses e quasi tutti i grandi artisti del passato. Si parla di situazioni dove ogni componente non è emerso solo per tecnica o qualità esecutiva, ma anche per la personalità e l’unicità nella timbrica del proprio strumento.
Ed è qui che a mio parere si sta sempre di più perdendo punti. I motivi sono molteplici: c’è la semplicità che ci offre la tecnologia moderna (per questo parlo di comodità) nel raggiungere determinati suoni. Una batteria di qualità con qualche trigger applicato da un
bravo fonico si raggiunge in pochi minuti, lavorare un suono registrato che mantenga pulizia, dinamica del batterista, rispetto per il suono dei fusti…significa lavorare per ore ed ore prima di un risultato valido. Microfonare una chitarra e raggiungere un suono
paragonabile a quello di un Kemper con un ottimo suono scaricato…il discorso non cambia.
Ma la realtà è che perfino il concetto di re-amp delle chitarre è un concetto che “toglie qualcosa”. Di certo dà maggiore qualità in minor tempo, ma chi suona la chitarra ben sa che la risposta della plettrata sull’amplificatore cambia di ampli in ampli e che si cambia
modo di suonare anche in base al “feedback” del tocco in relazione all’ampli. E se questa è la verità, come si può pensare di registrare un disco con un suono a casa propria, per poi spedirlo nella rete ad essere mandato in pasto altrove?
Certo, si risparmiano ore di studio, costi che non tutti possono permettersi e che probabilmente non permetterebbero la realizzazione di un buon disco e chiuderebbero molte altre porte, ma dall’altro lato bisogna prima o poi mettersi faccia a faccia con l’importanza reale che il timbro ha nel prodotto finale.
La musica è fatta di intonazione, ritmo e timbri ed oggi l’artificialità moderna vuole che l’intonazione si risolva (sopratutto per noi cantanti) con la correzione dei vari Autotune/Melodine/VariAudio, che il ritmo si risolva con quantizzazioni e che il timbro venga
affidato a degli “standard” di produzione che portano tanti, troppi dischi, a suonare “tutti uguali” nelle timbriche, per quanto personali e unici nella composizione. La perdita diventa così qualcosa di “nascosto”, “mascherato”, così mascherato che diventa
addirittura difficile rendersene conto per l’artista stesso, entusiasta per l’indiscutibile definizione e per la “pacca” del proprio prodotto.
Perfino i cantanti, che non possono “triggerarsi” la voce o “reamparla” spesso giocano la loro esistenza sulla ricerca di un timbro “che già funziona” senza mettersi in gioco. Una volta ho sentito un insegnante (un ottimo insegnante a mio parere) dire ad un allievo “tu cerca di prendere quella nota prima di tutto a modo tuo, poi preoccupati di capire se è un bel suono o brutto suono: prima di tutto sarà il tuo suono, ed il tuo suono non potrà mai piacere a tutti”. Se Freddie Mercury si fosse preoccupato di suonare “classico o sempre
corretto tecnicamente” ci saremmo potuti dimenticare dei suoi capolavori. Oggi tra i miei allievi vedo un sacco di voglia di cantare come “tizio”. Sono in pochissimi (ma trovo siano davvero quelli che possono dire qualcosa) quelli che durante le lezioni mi spiegano la loro voglia di riuscire a fare questo o quest’altro passaggio per ricerca personale, o mi mostrano la loro volontà di fare quel
brano “diversamente” perché l’originale “non gli piace in quella maniera”. La voce, tanto più in un mix sonoro fatto di trigger e reamp, diventa l’unico vero baluardo di personalità che una band ha. Se persino il cantante vuole “suonare come Coverdale” o “ricordare Dickinson/Kiske”, cosa resta di diverso da un fantacalcio musicale? Prendo il suono di chitarra di Gilbert, lo metto sul suono di basso di Steve Harris, ci metto la voce di Steve Lee ed i suoni di batteria di Lars Ulrich. Tutto bello, ma di vostro non ci sarà niente.
E se, riallacciandosi ai discorsi iniziali, di combinazioni musicali ne sono state fatte tantissime, la rete permette a tutti di mettersi in gioco, le etichette probabilmente produrranno qualsiasi disco, la tecnologia permette di registrare a prezzi bassissimi e
l’ascoltatore difficilmente sentirà più di un pezzo, come si potrà colpire una percentuale così bassa di potenziali interessati nel proprio prodotto, se persino l’unica cosa che davvero nessuna macchina può creare, viene lasciata alle macchine?
Il suono è l’unica cosa davvero unica che rimane al musicista.
La ricerca del proprio suono è la fonte vitale di qualsiasi musicista, e non può essere fatta attaccando una chitarra ad un preset o imitando la vocalità del proprio beniamino. E’ qualcosa di unico, di nostro che deve venire da dentro, che nasce dall’ascolto delle
discografie dei nostri artisti per capire come loro si sono evoluti nel tempo e nelle sfumature, non da un singolo brano ascoltato casualmente su Spotify. E’ una ricerca che non si fa solo con le orecchie ma con tanta voglia di conoscere la storia dei nostri artisti,
capire come loro si sono messi di fronte al proprio amplificatore, con il produttore o il fonico di turno, e per giorni hanno ricercato il tocco giusto per quel brano o semplicemente per far si che la loro mano scorresse come avevano in testa.
Oggi stiamo lavorando al contrario, adattiamo le nostre mani al preset che troviamo, per far sì che suoni bene, e non come abbiamo in mente. Adattiamo i nostri pattern ai trigger che li fanno suonare bene, adattiamo le nostre voci all’idea di chi canterebbe bene il nostro brano.
Il nostro suono è nella nostra mente, e va portato nelle vibrazioni per come lo ideiamo. Se manca l’idea, mancherà anche la personalità e di unico resterà poco.
Michele Guaitoli
ph: Beatrice Demori